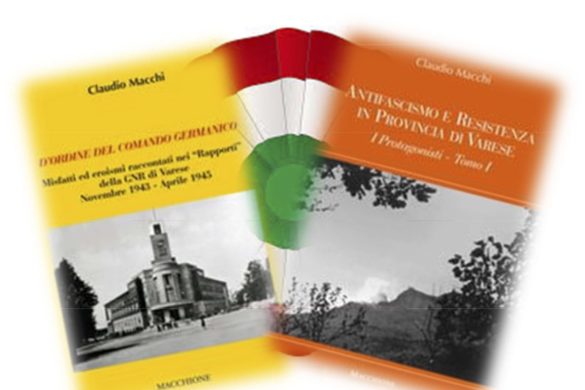SANT’ANTONINO (Lonate Pozzolo) – La testimonianza eccezionale di Enrico Vanzini, (classe 1922), l’ultimo ‘sonderkommando’ al campo di concentramento di Dachau, è andata in onda lunedì 18 maggio 2015 all’Oratorio di Sant’Antonino Ticino, frazione di Lonate Pozzolo. Quella di Vanzini è stata un’esperienza terribile che ha messo oggi sulla carta dopo sessant’anni in un libro di Rizzoli ‘L’Ultimo Italiano al Sonderkommando’. Riportiamo la nota dettagliata, già comparsa in internet, dell’incontro di Enrico Vanzini con il giornalista del ‘Corriere della Sera’ Roberto Brumat:
“Per la prima volta ospite a Verona, il Sig. Vanzini si è presentato agli alunni parlando della sua
giovinezza. Era un ragazzo spensierato di 18 anni a cui piaceva suonare il pianoforte e la
fisarmonica nelle balere del varesino. Tutto, però, cambiò quando fu chiamato a combattere al
fronte. «Ero destinato a partire per la campagna di Russia, ma un attacco di appendicite mi salvò
da quella esperienza. Così fui inviato ad occupare la Grecia». Ricorda con piacere la permanenza
ad Atene, fino all’8 settembre del 1943 quando, dopo l’armistizio di Badoglio, per l’esercito
tedesco gli italiani divennero dei traditori. Per undici giorni riuscì a nascondersi da loro, ma il 19
settembre venne catturato e, assieme ai suoi compagni d’armi, deportato in Germania. «Ci hanno
caricato in sessanta su un vagone. Più forte della fame era la sofferenza di non poter bere».
Giunto a Monaco l’11 ottobre del ’43 fu condotto nella cittadina di Ingolstadt, dove lavorò in una
fabbrica di chassis per panzer, lì vi rimase fino al luglio del ‘44. «Durante i bombardamenti
dovevamo rifugiarci assieme ai soldati tedeschi in una pineta nelle vicinanze della fabbrica». Un
giorno, però, una fortuita intuizione lo portò a cercare riparo, assieme ad altri due commilitoni
italiani, in una campagna poco distante. Quella mattina la pineta venne bombardata. Fu così che i
tre decisero di fuggire. «Seguimmo il corso del fiume con la speranza di giungere a Monaco». Una
sera stremati dagli stenti e dalla fame decisero di chiedere ospitalità in una casa lungo il cammino.
Una giovane ragazza italiana fece credere loro di volerli aiutare, ma in realtà li consegnò in cambio
di denaro, agli agenti delle SS. Accusati di evasione e di sabotaggio furono trasferiti a Buchenwald.
Lì il comandante, Hermann Pister, fu categorico: alle 04:00 sarebbero stati fucilati! «Ci scortarono
in un bunker sotterraneo. Chiusi lì dentro al freddo, attendevamo la morte». Una telefonata, però,
giunta al campo spiegò la dinamica dei fatti ed annullò l’esecuzione. La mattina seguente i tre
furono condotti in campi di concentramento diversi «A me toccò Dachau. Conclusa la guerra
cercai di rintracciarli, ma di loro non seppi più nulla».
Giunto al lager su una camionetta della Gestapo, appena varcò il cancello «Le prime cose che vidi
furono degli scheletri umani in marcia, un carro pieno di cadaveri e la recinzione elettrificata». Fu
condotto negli uffici delle SS dove sul polso sinistro gli fu impresso un numero a sei cifre «Non ero
più Enrico Vanzini, ma il numero 123343». Gli dettero una divisa lacera di cotone, sulla quale
apposero il triangolo rosso con la sigla “PI”(Prigioniero -di guerra- Italiano) e degli scomodi zoccoli
di legno. Non ebbe neanche la possibilità di tenere addosso la biancheria intima che indossava e,
rasato, lo condussero in quella che per sette mesi sarebbe stata la sua baracca, la numero 8.
«È iniziato l’inferno! Ci trattavano senza alcun briciolo di umanità, facendoci lavorare sotto le
intemperie dall’alba al tramonto». Lui fu destinato a riparare i binari della stazione, che erano stati
bombardati. «Dovevo sollevare pesanti traversine e rotaie di metallo ghiacciato. È così che mi sono
rovinato irrimediabilmente le mani… Non ho più potuto suonare». I sette mesi trascorsi nel campo
di concentramento lo fecero ammalare. Non ricevette alcun aiuto da parte degli infermieri del
campo a cui si era rivolto, ma sempre e solo bastonate. Fu un giovane internato russo che,
rischiando la propria vita, curò quelle ferite sottraendo dalle cucine dove lavorava, dei batuffoli di
cotone che imbeveva nello spirito «Grazie a lui, dopo otto giorni ho iniziato a stare meglio».
Il racconto è proseguito tra mille divagazioni che l’affannarsi dei ricordi inevitabilmente ha
comportato. Così, il sig. Vanzini si è soffermato sugli esperimenti compiuti all’interno del lager;
sulla solitudine provata perché l’unico italiano giunto al campo, con cui dopo lunghi mesi poteva
parlare, venne ucciso dopo pochi giorni; sui convogli carichi di ebrei che giunsero a Dachau e sulla
tremenda sorte che toccò a quella povere persone; sulla povera vecchietta che fu uccisa per dargli
un tozzo di pane che lui non mangiò mai e che, al suo rientro, la madre diede alla parrocchia del
paese come dono votivo; sulla disperazione che spingeva i detenuti a gettarsi sul filo dell’alta
tensione per porre fine a quelle sofferenze, mentre lui non perse mai la speranza «Signore, dicevo,
fai che possa riabbracciare la mia mamma!». Fino a giungere alla tremenda mattina quando
anziché essere mandato a lavorare in stazione, assieme ad un detenuto francese, fu costretto a
gettare i corpi degli internati morti, nei forni crematori. «Allora non lo sapevo, ma chi come me
veniva assegnato a quelle tremende mansioni, faceva parte di quelli che i nazisti chiamavano
Sonderkommando. Da quando il 1° ottobre del 2012 è morto Shlomo Bruno Venezia, sono l’ultimo
italiano di quelle unità speciali rimasto in vita». Seppe, nel corso degli anni, che in altri campi di
concentramento, chi svolgeva quella terribile mansione veniva trattato meglio degli altri internati,
ricevendo più razioni di cibo. Allo stesso tempo apprese che le SS, per paura che all’interno del
campo si potesse sapere cosa accadeva in quelle stanze a cui solo a loro era consentito l’accesso, li
uccidevano. «A me non toccò alcun vantaggio, ebbi tuttavia l’inspiegabile fortuna di essere
risparmiato». Vanzini lavorò per 15 giorni come Sonderkommando. «C’erano quattro forni, io ero
addetto a quello di destra, quello di sinistra era destinato agli ebrei, ma era quasi sempre chiuso,
mentre, quello centrale doppio era di competenza del mio compagno francese. Lui, prima di
abbandonare quei cadaveri alle fiamme, sulla loro fronte faceva il segno della croce». Lo strazio di
quei ricordi lo ha portato a parlare delle camere a gas «Qualcuno dice che a Dachau la camera a
gas non venne mai usata. Io li ho visti i morti soffocati. Li ho staccati a fatica gli uni dagli altri».
Furono giorni durissimi in cui la notte, il pensiero di ciò che aveva commesso durante il giorno,
dava spazio solo a terribili incubi. Ormai, però, quell’inferno stava per concludersi.
Il 29 aprile del 1945 gli americani entrarono a Dachau, salvando oltre trentamila persone. «Io non
avevo più la forza di stare in piedi, mi trascinavo sulle ginocchia ormai spellate. Il sangue malato
non circolava bene e se avessero tardato ancora un po’ sarei morto». Gli americani provvidero a
rifocillare, curare e vestire gli internati «Avevo per la prima volta: calze, mutande, maglia,
pantaloni, giacca, stivaletti e guanti». Dopo qualche settimana di quarantena, senza alcun
preavviso gli dissero che sarebbe ritornato a casa. Ricorda con emozione la mattina che rivide i
suoi genitori: «Mia madre mi guardò e mi disse: “Ma tu sei veramente mio figlio? Io non ti
riconosco”. Quando i tedeschi mi avevano arrestato pesavo ottantasei chili. Lasciai Dachau che ne
pesavo trenta».
Dopo il suo rientro, i genitori furono costretti a vendere ciò che possedevano per permettergli le
lunghe ed interminabili cure a Varese per farlo riabilitare e per dargli la possibilità di eliminare
quell’orribile marchio dal suo polso. Vanzini non parlò con nessuno di quella terribile esperienza.
«Quando nel ’45 tornai a casa, raccontai solo di essere stato in un campo di concentramento
tedesco, governato da aguzzini che mi avevano fatto sentire all’inferno. Niente di più, faceva
troppo male». Non ne fece parola neanche quando per il diciottesimo compleanno del figlio si
ritrovò a Dachau. La sua storia emerse per caso, dopo sessant’anni, a causa di una confidenza fatta
ad una signora che andava a casa sua a fargli delle iniezioni. Da allora i giornali se ne sono
interessati e lui, da nove anni, porta i suoi ricordi nelle scuole. «Inizialmente parlarne significava
sopportare che quelle immagini si riaffacciassero alla memoria”.