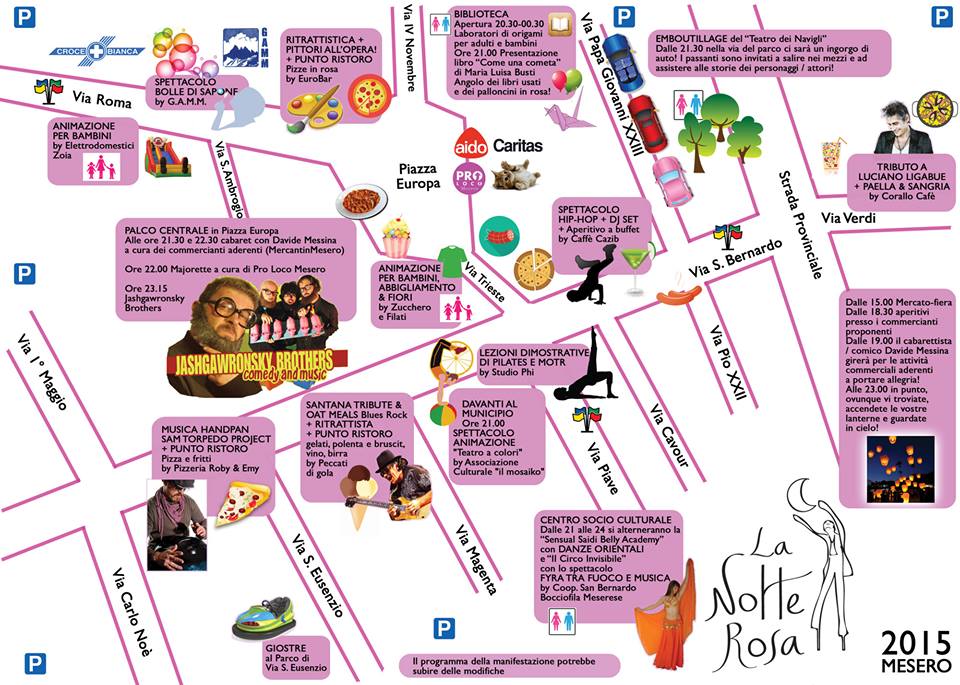Eccoci giunti al 3 dicembre 2016, il giorno prima del referendum che ha fatto tanto discutere nel nostro paese.
Domani, 4 dicembre, dalle 7 alle 23 gli italiani saranno chiamati alle urne per decidere il destino della loro costituzione,”la più bella del mondo”.
Nel corso di questi mesi si sono potuti ascoltare molti pareri, dai più tecnici ai più beceri. Quello che ora ci resta da fare è applicare l’articolo 138 della carta costituzionale.
[…]
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
[…]
Il referendum costituzione è lo strumento con cui il popolo stesso esprime la propria volontà, è espressione diretta di democrazia.
Perciò, dopo essersi ben informati, i cittadini non dovranno essere costretti ad un sì o ad un no. I cittadini, rispettati e liberi, sceglieranno secondo la propria coscienza, evitando di cadere vittime del terrorismo psicologico che oggi promette cataclismi in caso di vittoria dell’una o l’altra parte.
“Ogni cittadino domani abbandoni l’appartenenza politica e, nell’urna, sia italiano e si senta parte di un grande paese; voti con coscienza. Ognuno dovrà scegliere in merito ad una riforma con pregi e difetti” è ciò che si augura l’ex senatore Gian Piero Rossi, sindaco di Busto Arsizio per ben 7 volte.
Dunque, anche noi di Corriere AltoMilanese, abbiamo l’auspicio che domani gli italiani facciano la scelta migliore. Una scelta consapevole nei confronti del documento di maggior valore nella storia della Repubblica Italiana; espressione del compromesso tra molte parti politiche che non produssero la perfezione ma che seppero trovare un’intesa a favore del popolo italiano.
Fissiamo dunque l’appuntamento al dopo referendum lasciandovi con il discorso dell’Onorevole Ruini, pronunciato il 22 dicembre 1946 giorno in cui l’assemblea costituente approvò il testo definitivo. Vi serva come ultimo spunto di riflessione:
Questa Carta che stiamo per darci è, essa stessa, un inno di speranza e di fede. Infondato è ogni timore che sarà facilmente divelta, sommersa, e che sparirà presto. No; abbiamo la certezza che durerà a lungo, e forse non finirà mai, ma si verrà completando ed adattando alle esigenze dell’esperienza storica. Pur dando alla nostra Costituzione un carattere rigido, come richiede la tutela delle libertà democratiche, abbiamo consentito un processo di revisione, che richiede meditata riflessione, ma che non la cristallizza in una statica immobilità. Vi è modo di modificare e di correggere con sufficiente libertà di movimento. E così avverrà; la Costituzione sarà gradualmente perfezionata; e resterà la base definitiva della vita costituzionale italiana. Noi stessi — ed i nostri figli — rimedieremo alle lacune ed ai difetti, che esistono, e sono inevitabili.
[…]
Un giudizio pacato sui pregi e sui difetti della nostra Carta non può essere dato oggi, con esauriente completezza. Difetti ve ne sono; vi sono lacune e più ancora esuberanze; vi sono incertezze in dati punti; ma mi giungono ormai voci di grandi competenti dall’estero, e riconoscono che questa Carta merita di essere favorevolmente apprezzata, ed ha un buon posto, forse il primo, fra le Costituzioni dell’attuale dopoguerra. Noi, prima di tutti, ne riconosciamo le imperfezioni; ma dobbiamo anche rilevare alcuni risultati acquisiti.
I «principî fondamentali» che sono sanciti nell’introduzione, e che possono sembrare vaghi e nebulosi, corrispondono a realtà ed esigenze di questo momento storico, che sono nello stesso tempo posizioni eterne dello spirito, e manifestano un anelito che unisce insieme le correnti democratiche degli «immortali principî», quelle anteriori e cristiane del sermone della montagna, e le più recenti del manifesto dei comunisti, nell’affermazione di qualcosa di comune e di superiore alle loro particolari aspirazioni e fedi.
Nella enunciazione dei diritti e doveri dei cittadini, se la Francia, che ha una tradizione superba di tali dichiarazioni, ha potuto rimettersi ad esse, noi, che non l’abbiamo, siamo tenuti a formulare noi, per la prima volta, questi diritti e doveri. Lo abbiamo fatto non senza vantaggi e passi avanti; e qui le esigenze etico-politiche hanno ceduto il posto alla tecnica più precisa e concreta. Nessuna altra Carta costituzionale contiene un sistema così completo e definito di garanzie di libertà, ed alcuni istituti non sono privi di novità; mi hanno segnalato appunto la nullità delle misure di polizia non comunicate e convalidate subito dalla Magistratura, ed il diritto di associazione, inteso nel senso che chi ha diritto di svolgere singolarmente un’attività può farlo anche in forma costituzionale. Per il suo tecnicismo giuridico-costituzionale (e per la struttura e l’architettonica dell’intera Costituzione) la nostra Carta è una cosa seria.
Nessuno si deve scandalizzare se nei testi costituzionali è entrata — ormai da tempo — la nota dei rapporti economici. Le direttive che noi abbiamo formulato aprono, con la maggior adeguatezza possibile, la via a progressive riforme verso quella che deve essere ormai, lo abbiamo detto nel primo articolo, la democrazia basata sul lavoro; e nel tempo stesso escludono, proprio per lo sforzo di tracciare concreti istituti, i metodi rivoluzionari e violenti.
La seconda parte della Costituzione — ordinamento della Repubblica — ha presentato gravi difficoltà. Si tenga presente che nell’edificare la nostra Repubblica non abbiamo trovato, come in altri paesi, continuità di tradizione. Avevamo tutto da fare. Non abbiamo risoluto con piena soddisfazione tutti i problemi istituzionali. Ad esempio, per la composizione delle due Camere ed il loro sistema elettorale, rimesso del resto alla legge ordinaria. Ma in complesso si è seguita una linea media ed equidistante dai due estremi. Da un lato, dalle suggestioni, talvolta inconsapevoli, in cui cadono certuni che hanno sempre davanti agli occhi i congegni del passato, e non si sono ancora persuasi che il potere del re è per sempre caduto. Dall’opposto lato, dalle visioni degli estremisti che idealizzano un governo di assemblea e di convenzione, di cui tutti gli altri poteri sarebbero semplici commessi ed appendici. Ne ho parlato qui più volte; anche oggi confermo che le soluzioni adottate erano, dopotutto, le sole possibili, in attesa che l’esperienza indichi ulteriori processi ed adattamenti. Certo è che — pur non entrando nella via, almeno parziale, di alcuni poteri riservati al Capo dello Stato senza correlativa responsabilità ministeriale — il Presidente della Repubblica italiana è tutt’altro che un fantoccio. Certo è che, mantenendo la indeclinabile condizione della fiducia delle Camere, si è cercato di evitare le sorprese e la soverchia instabilità dei governi. E certo è — per ritornare alla parte tecnica — che più di ogni altra Costituzione la nostra definisce e precisa gli istituti del decreto legge, del decreto legislativo, della formazione e della gerarchia delle leggi.
Per quanto concerne la magistratura, vi possono essere rilievi e riserve; ma in sostanza si è fatto un passo decisivo, il solo possibile, non ancora raggiunto in molti altri paesi, verso la unicità della giurisdizione, con l’obbligo di trasformare in sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari le attuali giurisdizioni speciali, esclusi soltanto per necessità imprescindibili delle loro funzioni il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti.
La nostra Costituzione affronta lo spinoso problema dell’ordinamento regionale. Molti sono i dubbi; e vi possono essere inconvenienti; ma non si poteva non andare incontro ad una irresistibile tendenza; vi sono riforme storiche che non si possono evitare; e si sono di fatto predisposti i nuovi istituti in modo che la prova concreta e l’adattamento della esperienza, consentirà di dare ad essi maggiore o minore ampiezza, salvaguardando in ogni caso la necessità suprema della unità ed indivisibilità della patria.
Perdonatemi se ho creduto necessario rivendicare non solo le ombre, ma le luci della Costituzione. Si è fatto il possibile: nessuna altra Carta ebbe una più minuta preparazione; nessuna fu più a lungo discussa; per nessuna si è fatto con maggior completezza il punto, e si è condotto quasi un esame di coscienza di tutti i problemi più gravi del momento. È un eccesso? Sì; ma non è senza significato che un popolo, nell’accingersi ad un rinnovamento, abbia voluto compiere quest’esame di coscienza.
(Discorso dell’onorevole Ruini del 22 dicembre 1947. Seduta antimeridiana dell’Assemblea Costituente).